Quando passa la banda per le vie e le piazze del paese, con gli ottoni luccicanti, i fiati a squarciagola e le sue percussioni potenti, ne sono attratto come facevo da bambino, quando andavo dietro ad altre filarmoniche, nelle fiere dei paesi del sud dove sono nati i miei genitori, o quando seguivo le fanfare nelle parate militari, gonfie di retorica patriottarda, a ricordare antiche vittorie. Quando passa la banda vado dietro alla musica e ogni volta cresce sempre più dentro di me il senso di appartenenza a questa comunità: netta diventa la sensazione di avere portato a termine una lunga rotta e attraccato la mia anima nomade, non ancora pronta ad altre partenze, ad un approdo sicuro.
Da quindici anni ho qua la mia residenza, la mia famiglia e i miei nuovi amici, con i quali non ho fatto nessuna rivoluzione d’ottobre per occupare il Palazzo d’Inverno, ma talvolta ho consumato una cena a base di polenta e cinghiale al civet. In città, dove ho esaurito il mio primo ticket di quarant’anni, la condizione era anonima. In una piccola cittadina di provincia, qual è None, devi mettere la faccia e il cuore. Non è possibile vivere nel segreto delle proprie stanze. Si deve uscire allo scoperto, gettarsi nella mischia, confrontarsi con un sacco di gente.
Qua sono arrivato, con la stessa curiosità dei nuovi immigrati, che provengono dalle mille patrie, del sud e dell’est del mondo, dopo aver attraversato mari insidiosi e valicato montagne inaccessibili, con l’unico desiderio di integrarsi nella comunità del luogo. Io personalmente non ho dovuto fare molta strada, ma mentalmente sì.
Quando passa la banda, forse si ascoltano le stesse partiture e gli stessi suoni che hanno ascoltato le genti meridionali, arrivate in questo paese, a partire dagli anni Sessanta, alla conquista di nuove opportunità per un balzo nella gerarchia sociale.
Partivano da mondi agricoli, un po’ arcaici, consumati dalle rendite passive dei baroni latifondisti, e qua si insediavano portandosi dietro una profonda cultura politica e sociale, anti padronale.
A mio giudizio, None deve le sue sorti al dialogo difficile, ma fruttuoso, che si è stabilito tra le intelligenze migliori degli immigrati da una parte e degli ospiti dall’altra. Certo, c’era chi non affittava la casa ai meridionali, annebbiato dal pregiudizio che i nuovi abitanti fossero tanto diversi: brutti, sporchi e cattivi. Talmente sporchi da non conoscere la vasca da bagno, visto che, secondo alcuni, la utilizzavano come un piccolo orto domestico, per coltivarci il basilico e il prezzemolo, erbe simbolo della terra lasciata. Non c’è affatto da stupirsi se a quel tempo era un continuo proliferare di pregiudizi verso i meridionali. La prospettiva con cui la meridionalità è stata vissuta nel Paese, in quegli anni, non si discosta da quella di qualunque altro Paese che accolga genti forestiere: sicuramente i barbari servono, nonostante le loro parlate rozze, in quanto svolgono mestieri utili e risolvono un sacco di problemi, ma devono restare sempre confinati nella condizione di esclusi, di occupanti, di alieni, di uomini che sono usi a delinquere, sempre disposti a sobillare la quiete e l’ordine pubblico. E soprattutto non inclini alle abluzioni. Sì, gli stranieri servono, purché restino subalterni. Che non si azzardino ad ambire ad occupare gradini superiori nella scala sociale, altrimenti sono visti con diffidenza accompagnata ad un certo livore.
Ho provato ad immaginare come fosse None negli anni Cinquanta e Sessanta, leggendo le pagine del bel libro di Maria Dellacqua, “None – percorsi della memoria” (Ed. Alzani), là dove l’autrice affronta il tema dell’emigrazione, citando le testimonianze di coloro che, partiti dalla Puglia, Calabria, Sicilia e Sardegna, compiendo “un arduo percorso, quello di chiunque sia costretto a lasciare la propria terra, la propria gente, le proprie radici”, sono diventati a tutti gli effetti cittadini nonesi. Testimonianze che si accavallano, si sovrappongono, come il salmodiare di un coro greco.
“Quando sono arrivato qui ho sofferto. I primi due, tre anni sono stati duri. Ho pianto la miseria. Si piangeva senza volere! Sono morto il giorno in cui sono partito per il Piemonte. A me il Piemonte non piace… Sono partita per lavorare e guadagnare soldi … Via Stazione mi ha colpito. Ho visto tutta quella gente che lavava nelle bialere. Per me era tutto … quelle mucche che camminavano per il paese, la gente aveva gli zoccoli ai piedi. Mi ha fatto un po’ strano vedere tutto queste cose qui. Per me sembrava un altro mondo…” (pagg. 439-440).
Anche qua c’era un antico mondo contadino, con le sue stagioni, le sue tradizioni e i suoi riti, ma già si incominciavano a vedere in periferia, lungo la statale Torino-Pinerolo, ben stagliati nella campagna, i grandi insediamenti industriali, con la loro enorme ingordigia di risorse umane. Che sofferenza vederli oggi quegli stabilimenti trasformati in reperti di archeologia industriale, in cattedrali nel deserto, per colpa della devastante crisi che sta attanagliando i cuori della seconda generazione, ovvero di quelli che allora erano i figli di immigrati, nati a None o che qua giunsero in età prescolare!
Negli anni Sessanta c’era tanta nebbia. Qualcuno camminava per le vie del paese, nella stagione fredda, senza incontrare anima viva. Ritornava a casa e piangeva, nella nostalgia dello struscio, al cominciare della sera, lungo la strada più bella e importante del paese natale. Ma si riprendeva nei giorni della festa, quando la banda passava con l’allegria frastornante delle sue musiche. Dai racconti e dalle testimonianze di chi è arrivato qua in quei lontani anni, None aveva il profilo di un paese di frontiera, pronto però, grazie all’innesto di nuove genti sulla base autoctona, ad avere nel volgere di pochi decenni un grande sviluppo. L’integrazione tra le genti meridionali e i nativi è ormai un fatto compiuto. Quelle donne e quegli uomini sono diventati anche classe dirigente, che negli ultimi decenni ha amministrato e governa tuttora il paese. Nessuno dovrebbe più meravigliarsi di questa grande evoluzione. L’importante è che chi entra nel Palazzo abbia qualità umane e competenza tecnica. Sogno che questo paese possa essere, tra qualche anno, amministrato anche dai nuovi immigrati, magrebini o rumeni che siano, e che la banda, attraversando le vie e le piazze del paese nei giorni di festa, abbia in repertorio anche ritmi arabi e gitani.
lunedì 7 dicembre 2009
Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)

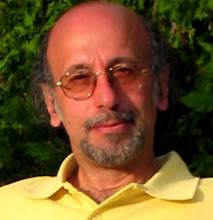

Nessun commento:
Posta un commento