Mario: Io ho un bellissimo ricordo della maestra unica. Allora era la classica figura di “seconda madre”, talvolta addirittura sostitutiva della “prima madre”, quando le nostre madri naturali erano divorate dal lavoro dei campi. Anche ora le madri sono prese dal lavoro, ma oggi sono piuttosto assenti.
Allora, in verità, c’erano delle madri piuttosto arcigne che si davano un gran daffare per sostenere la famiglia. Devo dire che le cure materne, che non ho avuto da mia madre, le ho avute da questa maestra. Ad esempio, quando ho avuto il morbillo o un’altra malattia esantematica, la maestra veniva a casa, così come faceva ogni volta che c’era qualunque altro suo alunno che stava male. Avete presente la preside di una scuola di Napoli (ndr La preside, Eugenia Canfora, del comprensivo “Raffaele Viviani di Napoli, vista nella trasmissione di Riccardo Iacona sulla scuola), telefona a casa e dice: “Guaglio’, che facimmo stammatina?” e si preoccupa di andarlo a prendere a casa per portarlo a scuola. È una preside tosta che accetta di reggere il conflitto con un ambiente ostile. Allora la maestra aveva a che fare, invece, con un ambiente che aveva bisogno di una forma di assistenza sociale, per così dire, laica. C’era da parte della mia maestra, come da parte delle altre, un grande affetto, che non era però un’ovatta. Mi ricordo la prima elementare, quando la maestra mi mise in mano delle penne. Lo fece forse con una certa violenza, nel senso che un bambino a quell’età vorrebbe soprattutto giocare. C’erano in me in ogni caso gioia ed entusiasmo e forse devo a lei la scelta di fare lo stesso mestiere di insegnante. Per me era un fatto normale la “maestra unica”. Si stava a scuola dalle 8.30 alle 12.30. Allora era un altro mondo. Adesso è un po’ più complicato. Educare un bambino adesso penso che sia molto più difficile e certamente c’è necessità di avere più figure di riferimento.
Mariella: Anch’io ho avuto una “maestra unica” e ho avuto con lei una bellissima esperienza. Forse era un po’ più severa della tua. Però ha saputo insegnare i valori e con competenza tutte le materie. Se, infatti, non ho avuto lacune lungo il mio percorso scolastico, è grazie al suo insegnamento. Detto questo, però, sono conscia del fatto che e è stata una gran fortuna, perché incontrare una insegnante con quel carisma e quella competenza allora era possibile. Adesso ritengo che sia indispensabile la presenza di due o più figure di riferimento, perché quello che manca a una può essere colmato da un’altra. Poi, va detto che allora era, come dici tu, veramente un altro ambiente con bambini e genitori assolutamente diversi. E un unico insegnante poteva reggere l’ambiente circostante.
Mario: Sì, allora c’era un rapporto diverso tra insegnanti e genitori. Questi si occupavano meno della scuola. C’era una specie di delega fiduciaria. Adesso i genitori certamente si preoccupano maggiormente della scuola dei loro figli, ma in linea di massima fanno danni. Diciamo che il loro interesse emerge nel momento in cui il figlio prende sei piuttosto che sette, oppure per sostenere che la mensa non è all’altezza del sano appetito del ragazzo. Insomma, è un interesse individuale, non partecipativo. Un po’ rivendicativo e petulante.
Ilenia: Io ho avuto due insegnanti. Una di vecchio stampo, molto severa. L’altra alle prime armi. Molto giovane. C’era sicuramente differenza tra l’una e l’altra. In ogni caso, seppure diverse, erano entrambe molto preparante e positivamente influenti sul mio apprendimento. A mio giudizio, per quanto riguarda i genitori, sono cambiati solo negli ultimi anni. Perché quando andavo a scuola io, e parlo dei primi anni novanta, andare a casa con una nota, che fosse giusta o sbagliata, erano guai. E non parlo solo di mia madre, che partecipava molto alla vita scolastica di noi figlie, ma anche dei genitori dei miei compagni che si comportavano nello stesso identico modo.
Antonella: Io posso parlare sia come insegnante, sia come madre e, a seconda del ruolo, cambia naturalmente il punto di vista. Anzitutto va detta un’amara verità: purtroppo ci sono anche insegnanti che valgono poco. E quindi è anche giusto che il genitore vada a scuola ad esporre le proprie lamentele. Ci vogliono soltanto la giusta misura e buona educazione, perché, parliamoci chiaro, nella nostra categoria ci sono docenti che svolgono questa delicata professione, non per scelta, ma perché non sapevano che altro fare nella propria vita.
Gregorio: C’erano anche allora insegnanti che sapevano poco di pedagogia. Adesso noi insegnanti per lo più siamo adeguatamente formati, sia dal punto di vista cognitivo che affettivo. Faccio due esempi, presi dal mio vissuto e da quello di un mio caro cugino. In questo contesto, credo di essere il più vecchio di tutti. Ebbene io sono andato a scuola a metà degli anni cinquanta, entrando in una scuola molto selettiva, dove gli alunni erano già predestinati ad un certo tipo di percorso formativo, al di là dei propri meriti, competenze e abilità. Se eri figlio di operaio, come io ero, avresti dovuto seguire il cammino della fabbrica. Fortunatamente, però, mio padre con molta tenacia ha voluto offrirmi altre opportunità. Tornando all’analisi della scuola che ho frequentato, i mancini ad esempio, subivano immediatamente, una volta entrati a scuola, una forma di violenza, perché assolutamente dovevano imparare a scrivere, impugnando la penna con la destra. Questo mi sembra assolutamente antipedagogico. Per fortuna non accade più. E per evidenziare ancora di più la carenza di qualsivoglia preparazione pedagogica degli antichi unici maestri, voglio fare l’esempio di mio cugino. Era un bambino svogliato, privo di qualsiasi autostima. Il maestro, in questo caso parlo di un uomo rozzo, assolutamente incapace di svolgere il ruolo di educatore, cosa faceva? Lo emarginava. Invece di motivarlo ed esaltarne le indubbie capacità per un opportuno progetto di vita, lo escludeva, mettendo ogni giorno sul suo banco un foglio su cui era scritto l’epiteto “asino”. Credo che questa scarsa considerazione da parte del maestro nei suoi confronti, ovviamente insieme ad altre ragioni esistenziali, lo abbia talmente condizionato da portarlo alla depressione e a scelte suicidarie. E, credetemi, non è una spiegazione campata in aria. Avete mai sentito parlare dell’effetto Pigmalione? Se un docente rimanda un’immagine positiva ad un ragazzo, quello riceve del valore aggiunto che lo stimola allo studio e lo rende un alunno più disponibile. Questo insegnamento pedagogico ho ricevuto.
Antonella: Mi viene da pensare che ai giorni nostri, dopo decenni, con la tecnologia, il benessere sociale e quant’altro, che, alla fine delle fiera, il bambino non sia poi così centrale, ma non dal punto di vista della scuola, ma da quello della politica e della società. Chi è che tutela i minori? Tenendo conto dell’influenza dei mass media, chi è il garante? La scuola cosa deve fare? La famiglia cosa deve fare? E un rimpallarsi di responsabilità tra l’una e l’altra agenzia educativa. Parliamo tanto della centralità del bambino, del suo percorso educativo, del suo benessere psicofisico, e poi, tutto va a gambe levate perché al bambino non vengono forniti gli strumenti per metabolizzare concetti di un mondo prevalentemente adulto.
Mariella: la responsabilità è del legislatore. Possiamo dire tranquillamente che la riforma Gemini con i suoi otto articoli non è in grado di venire incontro all’esigenza da te espressa, perché non contiene nessun requisito pedagogico. La scuola, che ancora cerca di resistere alla tempesta gelminiana, con il tempo pieno, il tempo modulare, è in grado di soddisfare quello che dici. Abbiamo investito di più sulla scuola elementare, facendola diventare una delle migliori al mondo.
Antonella: Sapete perché dico questo? Purtroppo arriva il genitore, per confrontarsi con l’insegnante sul comportamento del figlio, che già in seconda o terza elementare palesa atteggiamenti precocemente adolescenziali, e chiede cosa possa fare per correggerli. Ebbene, è difficile per un insegnante dargli le risposte giuste. Abbiamo a che fare con un concorrente sleale che è la televisione, probabilmente la più accreditata agenzia formativa dei giorni nostri. Ahinoi!
Mario: una volta non c’era tutta questa concorrenza. Adesso il maestro, la figura educativa, diciamo pure carismatica se riesce, non è l’unico modello offerto e quindi entra in competizione. Ed è senz’altro difficile vincere con quei modelli lì, analogici o digitali che siano.
Antonella: Qualche volta io mi adeguo e, per riprendere i miei bambini, magari uso il linguaggio di certi personaggi televisivi. Mi sembra che capiscano meglio. Poi, cerco di spiegare il meccanismo della comicità, perché certi personaggi fanno ridere.
Mariella: Spiegando queste cose, svolgi il tuo ruolo educativo nel modo migliore. Ma con la contrazione del tempo scuola, questo tipo di intervento utile a dare ai bambini e ai ragazzi una consapevolezza critica è vanificato. Come può un unico insegnante con quattro ore al giorno fare queste cose?
Nunzio: Anch’io ho un buon ricordo della maestra elementare. Intanto mia madre ha fatto di tutto per non inserirmi in classi, dove l’insegnante utilizzava magari la bacchetta o scatenava forme di competizione esasperate tra i bambini. Comunque, anche la mia maestra faceva la lezione frontale. Non bisognava dire nulla, ma ripetere pedissequamente la lezione, una volta interrogati. Questa modalità al sottoscritto in particolare creava parecchi problemi, perché c’era stata una zia che a me e ai miei fratelli, prima del mio ingresso a scuola, aveva insegnato parecchie cose. Il mio apprendimento domestico, con questa mia parente, era avvenuto nel piccolo gruppo. Invece, in classe, ognuno doveva restare fermo nel suo banco e non agire interattivamente. Eravamo tutti inquadrati: eri semplicemente un numero e la tua individualità non veniva affatto esaltata. Mancava l’esercizio all’autoelaborazione. Secondo me, francamente tornare indietro, è deleterio. Insomma, la questione è la seguente: qual è il contesto, il modello pedagogico migliore da proporre? Dovrebbe essere chi governa a decidere oggi, anno 2009, allo stato dell’arte e della conoscenza, della statistica e della ricerca, se sia meglio per la sua crescita tenere il bambino a casa - con la nonna, la mamma o la baby sitter - oppure stare in un ambiente educativo ben integrato, per otto ore. Di questo, insomma, dobbiamo preoccuparci: fornire ai nostri figli il modello pedagogico più opportuno, naturalmente con docenti preparati e competenti, che ben rispondano alla volontà della società di formare cittadini consapevoli.
martedì 31 marzo 2009
Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)

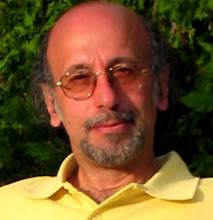

Nessun commento:
Posta un commento